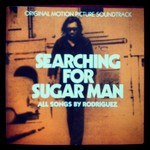 Milano, Auditorium, 22 marzo 2014
Milano, Auditorium, 22 marzo 2014
È difficile non essere romantici davanti a storie del genere. Dall’emarginazione alla salvezza. Dalla sconfitta alla liberazione. Come dopo un lungo e violento diluvio. Quando il cielo schiarisce, le nuvole si diradano, il sole scintilla nelle pozzanghere in strada. Il diluvio è stata la Sua vita, nella parte povera di Detroit, operaio carpentiere, le braccia forti d’immigrato che rendono macerie le forme scartate che non servono più. La nuova luce l’abbiamo davanti a noi, è Lui stesso, ora, sul palco.
Sixto Rodriguez incise due dischi nei primi anni ’70, Cold Fact e Coming from reality; echi dylaniane in un folk blues dolce quanto malinconico, in cui ai temi sociali si univa l’esistenzialismo di uno sguardo poetico nella vita di strada. Nonostante le ottime recensioni vendette poco, la casa discografica non gli rinnovò il contratto. Rodriguez dovette così abbandonare la sua arte provvedendo da lì in poi alla Sua famiglia “solo” con la fatica del suo lavoro. Tanto. Mal pagato. Faticoso.
Proprio negli anni in cui lo show business recitava il gran rifiuto verso la sua arte, a sua insaputa il movimento anti-apartheid sudafricano aveva fatto delle sue canzoni gli inni della propria lotta. Rendendo Rodriguez un mito, al pari di Elvis. Da idolatrare e raccontare. Intorno alla sua figura aleggiavano strane storie – si era ucciso sul palco, era morto di overdose in carcere – nella loro contraddizione recitavano tuttavia la medesima certezza. Rodriguez è morto. Rodriguez invece era vivo e continuava a lottare. Anche per loro.
Dopo aver cambiato una ventina di appartamenti a downtown Detroit si era infine stabilito nella casa che abita ancora oggi, dopo quarant’anni. I suoi colleghi lo vedevano arrivare al lavoro elegante come un principe e sereno come un maestro: senza tante parole raccoglieva gli arnesi da lavoro e iniziava a distruggere. Quelle stesse mani che accarezzavano la chitarra come i capelli di una ninfa innamorata della tua poesia. Impegnato nella vita della comunità, lui, immigrato di origini messicane, si era anche candidato sindaco. Dalla narrazione degli ultimi voleva accedere alla loro protezione e azione politica. Non era stato eletto, naturalmente.
Poi il miracolo. I suoi fan sudafricani vogliono vedere chiaro sull’identità del loro idolo, sulla sua fine. Con l’avvento di internet aprono un blog, un giorno arriva un messaggio da Detroit. Una ragazza scrive di essere una delle figlie di Rodriguez. Il poeta si ricongiunge al proprio pubblico, alle sue stesse parole. Il mito torna a se stesso, la realtà decide di raccontarsi.
Il 6 marzo 1998 il Sudafrica ormai libero dalla vergogna dell’apartheid abbraccia il primo, gremito, atteso, benedetto concerto di Rodriguez. Un trionfo. Lacrime. Applausi. Il cerchio magico della vita che abbraccia chi prima aveva escluso.
Questo miracolo è stato narrato nel documentario Sugar Man vincitore l’anno scorso del premio Oscar. Questo miracolo ho avuto la fortuna di conoscere e condividere, e, ieri sera, vedere sul palco dell’Auditorium di Milano. Mi sono commosso ieri sera a vederlo, mi commuovo ora a scriverne.
Rodriguez è accompagnato sulla scena, a braccetto, il passo lento e insicuro, curvo sulla schiena. Uno strano silenzio scende sulla sala dopo gli applausi iniziali. Percepisco il timore fra il pubblico che Rodriguez non riesca a ripetere il prodigio cui abbiamo assistito nel documentario. Indossa gli occhiali scuri, un grande cappello nero, imbraccia la sua chitarra.
Pensavo è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo incominciare una chitarra cantava Faber. Penso io è bello che Rodriguez abbia sempre mantenuto questa dolcezza con cui ha lasciato scorrere il destino. La dolcezza con cui le sue dita scivolano sulle corde della chitarra. Di nuovo l’immagine, potente, dalla distruzione dell’occupazione operaia alla creatività sincronica della musica.
Love me or leave me di Nina Simone, il ritmo inquieto nella vitale contraddizione dell’amore, apre le danze. Rodriguez oppone alla rigidità antica, ormai, del corpo suo, vecchio guerriero, la purezza quasi infantile del sorriso e delle parole. Le canzoni di Sugar Man sono sfogliate con destrezza mentre il richiamo a Elvis della cover graffiante di Blue suede shoes nasconde sotto il manto dell’omaggio al Re lo sberleffo scanzonato all’America e ai suoi miti. Rodriguez suona anche il rock. Lucille di Little Richard è gridata come una piccola ribellione dentro la scenografia sempre nostalgica delle sue altre perle. Dopo un’ora di concerto Rodriguez esce di scena, poco dopo vi ritorna, senza più la giacca, in seguito ad un’ovazione.
Il sangue nativo americano che gli scorre nelle vene lo aiuta e lo determina nella serenità e nel silenzio. Sembra uno sciamano. Ringrazia, con onore. Fever, l’ultima cover prima del saluto, un’ora e mezza di musica, una lezione non quantificabile. Grazie a te Rodriguez.
Quale sottile linea (rossa) divide e unisce il talento dal destino. Possiamo, dobbiamo inseguirlo. Ma certo è solo Lui che ci troverà. Cerchiamo di meritarlo, cerchiamo di sorridergli, anche se vorremmo insultarlo. Aspettiamolo, senza sperare, senza pensare, concentriamoci sulla nostra arte, lasciamo scorrere la rugiada… Rodriguez l’ha fatto. Rodriguez è vero.
La Comune di Parigi, il Grande Torino, Madame Bovary, i Malavoglia, Wounded Knee. Tutto l’intero ciclo dei Vinti appare in lui riscattato. Quanto dolore, e talento nascosto, rifiutato, ignorato c’è oggi, penso, mentre cammino nel Ticinese sulla via verso casa. Mi ricordo d’ esser puro, di restare nobile, sempre, qualunque cosa succeda. Come lui.
Diluvia su Milano. Per cinquant’anni ha diluviato su Rodriguez, lui non ha mai ceduto al richiamo del rancore, non è caduto nella ribellione facile della tristezza. Ha lottato. Ha sorriso. Quale insegnamento si respira da questa storia, quale illuminazione. Non hai avuto successo Rodriguez, fratello mio, ora hai la Gloria, l’immortale stele della Bellezza possa coprirti la schiena curva di lavoro.
Sciamano dolce, guerriero bambino, ti sia lieve il tuo nuovo, vero Destino.


